

LUNGO IL BIOTýS
La "passeggiata" Ŕ interessante per l'ambiente aspro e selvaggio in cui si
svolge, e per le considerazioni che a riguardo possono essere fatte. Senza
forzare la si percorre in meno di due ore. Consiglio due periodi: inizio primavera
oppure tardo autunno. E' inoltre indispensabile che non ci siano state
precipitazioni consistenti in precedenza: si deve infatti attraversare il
torrente in pi¨ punti, per evitare passaggi che richiederebbero attrezzature
particolari.
Grado d'impegno richiesto:
***
Vanno utilizzate calzature robuste e con buon grado di protezione, in
considerazione del percorso accidentato, con pietre, ciottoli e continue
risalite sugli argini.


Dai pressi della casa CostesŔle, circa 20 m a Ovest, si comincia a scendere
verso il vallone sullo spigolo della collina, costeggiando nel tratto iniziale
una vigna (la piccola "storica" vigna ora Ŕ stata estirpata. Febbraio 2016). Dopo un breve tratto in lieve discesa, la pendenza cresce; in vista
della parete quasi verticale sull'altro versante, al margine di un boschetto con larici diventa pi¨
marcato il sentiero, che scende
a sinistra e con due tornantini porta sul greto del torrente Biotýs, pochi metri
a monte di un imponente sbarramento sul torrente. La profonda forra Ŕ su una
faglia, che ha condizionato il corso del torrente costringendolo ad una virata
verso ovest: evidente la diversa natura della roccia e dell'inclinazione degli
strati sui due ripidissimi fianchi. Due gli sbarramenti, a una distanza di circa
trenta metri; a monte il pi¨ imponente: costruito ad arco, per sopportare la
spinta della enorme massa di materiale che ha riempito l'invaso, formando un
ampio pianoro. Un sentiero, segnato come Sent.
Naturalistico nella cartina sopra a sinistra, permette la risalita, sul
fianco destro, in modo da superare le due serre; i tratti che superano le briglie,
sul lato destro del torrente, sono pericolosi, per la presenza di detriti ed
erosioni che li possono rendere
scivolosi, in assenza di funi e protezioni; il sentiero risale poi l'altra
sponda del torrente, fino alla strada Rasai-Valorna. Un video su YouTube
relativo a questa forra: Mole
https://youtu.be/gdP6Us2XjfI.
La costruzione della diga a monte deve essere iniziata in
tempi remoti, per frenare la copiosa erosione operata dalle acque che la
pendenza eccessiva rendeva tumultuose,
col materiale che finiva a invadere e danneggiare
il paese di Rasai; la serra Ŕ stata rialzata in pi¨ fasi: si trova una conferma nelle
"notizie" dell'arciprete di Rasai G. B. Segato: "ANNO 1858-1859: Fu
eseguito il restauro e rialzo del Serraglio del torrente Biotis alla chiusa in
Vallorna, per una metÓ a spese erariali, per l'altra a spese dei limitrofi
possidenti, uniti in consorzio" (non Ŕ Valorna la localitÓ delle serre, ma
"Le Mole": con gli spessi strati di roccia calcarea del fianco sinistro
probabilmente si ricavavano delle mole, da cui il nome). In seguito fu costruita la
briglia a valle, per impedire che l'erosione scalzasse dal basso la diga
principale. Un nuovo "rialzo" intorno agli anni '30, nel caratteristico stile
del "ventennio", come si nota nell'immagine a fianco; qui si vede anche parte
della liscia parete sul fianco sinistro del torrente, probabilmente uno "specchio" della faglia.
Evidente anche la pendenza dei conci su cui scorre l'acqua prima del salto: un
motivo in pi¨ per tenersi lontani dal bordo.
rendeva tumultuose,
col materiale che finiva a invadere e danneggiare
il paese di Rasai; la serra Ŕ stata rialzata in pi¨ fasi: si trova una conferma nelle
"notizie" dell'arciprete di Rasai G. B. Segato: "ANNO 1858-1859: Fu
eseguito il restauro e rialzo del Serraglio del torrente Biotis alla chiusa in
Vallorna, per una metÓ a spese erariali, per l'altra a spese dei limitrofi
possidenti, uniti in consorzio" (non Ŕ Valorna la localitÓ delle serre, ma
"Le Mole": con gli spessi strati di roccia calcarea del fianco sinistro
probabilmente si ricavavano delle mole, da cui il nome). In seguito fu costruita la
briglia a valle, per impedire che l'erosione scalzasse dal basso la diga
principale. Un nuovo "rialzo" intorno agli anni '30, nel caratteristico stile
del "ventennio", come si nota nell'immagine a fianco; qui si vede anche parte
della liscia parete sul fianco sinistro del torrente, probabilmente uno "specchio" della faglia.
Evidente anche la pendenza dei conci su cui scorre l'acqua prima del salto: un
motivo in pi¨ per tenersi lontani dal bordo.
Terminata l'osservazione della gola de "Le Mole" (prudenza!), si segue
l'alveo del
torrente sul ripiano generato dai detriti trattenuti dalla diga, oppure si
percorre una traccia di sentiero tra i cespugli sulla destra del Biotis (risalendo
a sinistra). Giunti in vista di altri due modesti sbarramenti sul torrente, li
si pu˛ comodamente superare risalendo a destra (riva sinistra), dove si
trovano le tracce di sentiero e i resti di una cava di roccia, utilizzata per
costruire le vicine briglie. Lasciamo il sentiero e di nuovo scendiamo sul greto
del torrente (seguendo il sentiero, molto ripido, si potrebbe raggiungere la
strada che da Rasai porta in Valorna). Il percorso si va facendo sempre pi¨
accidentato, a causa delle pietre pi¨ voluminose e dei fianchi pi¨ ripidi,
talvolta in roccia quasi verticale. In vista di un enorme masso che sembra
chiudere la valle, si risale l'argine a sinistra (riva destra), per evitare le
rocce di due valloni che precipitano sul Biotis dalla Costa Campi˛n, il costone sopra la
"strada di Valorna". Man mano che ci si avvicina alla pietra, ci si rende conto
della sua enorme mole: abbiamo raggiunto il Sass del
Termen˛n. Questo enorme masso, con buona probabilitÓ, Ŕ stato
trasportato in zona dal ghiacciaio della Val Cism˛n, che concorreva nella
vallata feltrina con quelli provenienti dal Piave e dal Cordevole; una frana di
roccia, staccatasi forse dalle "Vette" o dal Tot˛ga, diede
origine al Termen˛n e a vari altri grossi massi vicini, un po' pi¨ a monte del
gigante: nel lungo tragitto sono stati levigati e hanno perso le originarie
forme squadrate. L'immane pietra Ŕ coperta da erica, cespugli e altra
vegetazione: alla sommitÓ vive un larice pi¨ alto del medesimo Sass,
e imponenti pecci.


Nell'immagine sopra a sinistra, il lato Nord del Sass del Termen˛n, mentre in quello a destra si vede la parte sommitale del fianco ovest, rivolto al torrente: sulla destra in alto un vecchio larice, in cima un enorme peccio. Il lato Sud Ŕ lambito dal Biotýs, e ne vediamo la parte orientale e quella centrale nelle due immagini qui sotto.


Lasciamo il Sass del Termen˛n e, continuando
l'escursione, risaliamo il greto e passiamo sulla riva opposta al Sass. Il
torrente qui Ŕ assai tormentato, ci conviene salire pi¨ in alto per evitare dei
passaggi impegnativi e scivolosi in mezzo a grossi macigni , e percorrere un
tratto sulla costa, pure assai ripida. Passati a monte di uno spuntone
verticale, puntiamo nuovamente verso il greto del Biotýs, e vi scendiamo lasciando a valle due
grandi macigni, non paragonabili al Termen˛n, ma pure imponenti: forse suoi
compagni nel millenario viaggio a cavallo del ghiacciaio. Questa parte del
torrente ha subýto una profonda trasformazione negli anni trascorsi da quando,
col solito gruppi di ragazzi, si percorreva in poco tempo tutto il torrente,
fino al Calier˛n senza incontrare difficoltÓ, col pretesto di cercar chiocciole perfino nei giorni di
sole. In certi punti la sponda Ŕ stata
profondamente erosa, in altri si Ŕ innalzata copiosamente per il deposito di
grandi quantitÓ di materiale: l'evento che ha sconvolto questo tratto di
torrente, dopo il 4 novembre '66, Ŕ stata la pioggia torrenziale del 20
settembre 1999, di cui si parla in altra pagina.
nuovamente verso il greto del Biotýs, e vi scendiamo lasciando a valle due
grandi macigni, non paragonabili al Termen˛n, ma pure imponenti: forse suoi
compagni nel millenario viaggio a cavallo del ghiacciaio. Questa parte del
torrente ha subýto una profonda trasformazione negli anni trascorsi da quando,
col solito gruppi di ragazzi, si percorreva in poco tempo tutto il torrente,
fino al Calier˛n senza incontrare difficoltÓ, col pretesto di cercar chiocciole perfino nei giorni di
sole. In certi punti la sponda Ŕ stata
profondamente erosa, in altri si Ŕ innalzata copiosamente per il deposito di
grandi quantitÓ di materiale: l'evento che ha sconvolto questo tratto di
torrente, dopo il 4 novembre '66, Ŕ stata la pioggia torrenziale del 20
settembre 1999, di cui si parla in altra pagina.
Ritengo che questo tratto sia quanto mai predisposto alla formazione di quelle
"bombe d'acqua" che, in particolar modo in periodi recenti, hanno seminato lutti
e distruzioni, con torrenti di fango che hanno sventrato i centri abitati.
Numerosi e robusti tronchi posti di traverso nell'alveo, restringimenti con massi che
fungono da blocco temporaneo, grande disponibilitÓ di detriti d'ogni genere,
riescono ad arrestare le acque che formano dei laghetti temporanei: questi poi
"esplodono" per la pressione dell'acqua e col carico di fango, pietre e tronchi travolgono la zona a valle.
Qui a fianco un'immagine dell'alveo del torrente con numerosi tronchi di traverso, precipitati
per l'erosione della sponda destra: i due
faggi, in fondo, sono imponenti e riuscirebbero a bloccare i detriti e deviare l'acqua,
provocando altre erosioni e la caduta di altri tronchi. Immaginiamo che cosa potrebbe capitare se, in seguito a una
piena rovinosa, alberi di queste dimensioni fossero trascinati fino in fondo al
torrente e si ponessero di traverso sotto il ponte a Est di Rasai: l'effetto diga porterebbe il
torrente a straripare in un punto estremamente delicato, dove il torrente non
potrebbe rientrare negli argini perchÚ corre pensile rispetto al terreno
circostante in entrambi i lati.

Nell'immagine qui sopra, un luogo che sembra fatto per creare
le "bombe d'acqua": due massi costringono il torrente in una
strettoia, che si intasa per l'apporto di tronchi e cespugli, trattenuti dalle
rocce, in occasione delle piene; si notano infatti resti di tronchi
formanti una barriera tra le due rocce, lasciata lý da una piena.
Proseguiamo ancora qualche decina di metri, e notiamo sulla riva destra del
torrente (a sinistra salendo), un sentiero con una profonda erosione nel punto
in cui scende nel torrente: il sentiero detto "tr˛i dele Coste" o "tr˛i dele B˛e",
che seguiremo lasciando il vallone del Biotýs. (Il sentiero continua anche sulla
riva sinistra e, dopo un bosco di faggio in lieve pendenza, con tracce di
vecchie piste
per esercitazioni con motocross, attraversa il prato "de Bin"
con casera, e poi
confluisce sulla "strada de Valorna" che a sinistra (a monte),
porta al Calier˛n, a destra scende a Rasai). Con la massima attenzione, per
evitare di provocare ulteriori erosioni al sentiero e di finire nel torrente con
un pericoloso salto (se pi¨ persone, passare a debita distanza l'uno dall'altro per non caricare
il terreno -Le brentane dell'autunno 2012 hanno
ulteriormente eroso la riva: ora si deve aggirare in alto la frana per
immettersi nel sentiero-), si inizia la risalita sul sentiero evidente e ben marcato, che dopo il salto
iniziale diventa quasi pianeggiante. Si attraversa un terreno con giovani piante
di carpino e altre varietÓ di piante pioniere, che per prime si diffondono sui
prati e
li colonizzano.

Si intuisce cosý che non molti anni fa -non pi¨ di trenta-
qui c'era un prato completamente privo di vegetazione arborea, se si eccettua
qualche albero da frutto e una vite mericana, che ha opposto una lunga
inutile resistenza a frassini e carpini, prato ricavato molti anni prima
espiantando il bosco. Allora non solo il legno dei tronchi veniva utilizzato
(non esistevano riscaldamenti centralizzati, e anche nelle cittÓ, se non si
utilizzava il carbone, la legna era l'unico combustibile), ma anche quello dei ceppi:
una volta strappati al terreno, erano fatti a pezzetti per essere anche venduti;
i genitori mi parlavano "de quei che vŔa a vÚnder fh˛cc a Fheltre" (di
quelli che andavano a vendere ceppi a Feltre). Naturalmente, dove c'era un prato
si tagliava l'erba, e si portavano le vacche a pascolare o mangiare il fieno lý
prodotto:
infatti incontriamo i resti di una "pendÓna" o "cas˛n" (i tre muri perimetrali,
non pi¨ tracce del tetto) che vediamo sopra. Pochi metri pi¨ avanti una piccola "casera"
in parte pericolante e puntellata, ma non ancora crollata. La zona Ŕ denominata
"le Coste". Il sentiero, con lieve pendenza, entra in una valle che
ha, a monte, una zona franosa e ricca d'acqua (Val dei C˛rn); oltre questa
diventa ripido e, superato un costone, entra di nuovo in una vallecola con
residui di frane: per questo il luogo Ŕ chiamato "le B˛e". A monte del punto di attraversamento, una briglia sulla cui
destra svetta
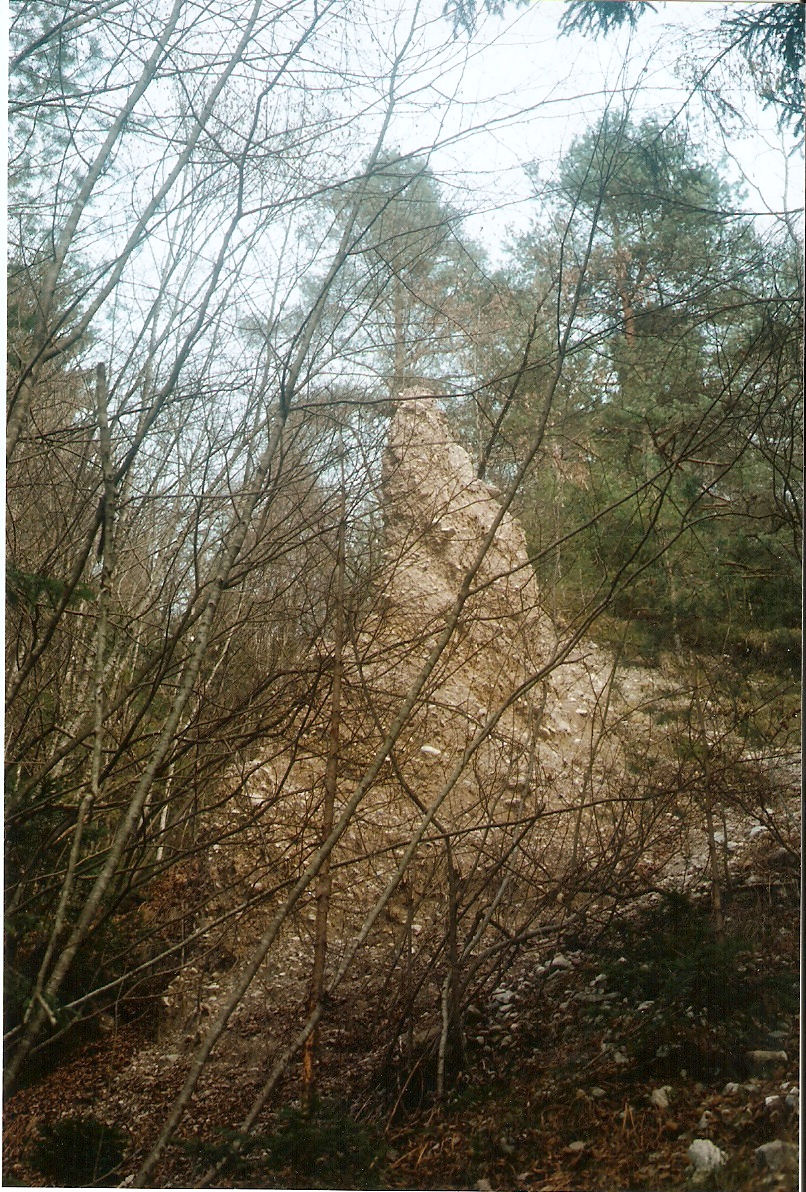 uno strano calanco, isolato: Ŕ chiaro che uno strato di materiale di
spessore superiore all'altezza del calanco Ŕ stato asportato dalle frane in tempi non
molto remoti (vedi l'immagine dello stesso nel
1985); anche a
valle emerge un altro calanco, e sono presenti altre briglie che hanno ormai stabilizzato il terreno. Si risale una costa con rada vegetazione di stentati
carpini e ornielli, tipici di ambiente secco e terreno non profondo, e si ha di fronte una frana imponente (B˛e de Rubýn), che si
sta mangiando la sommitÓ di una
collina: anche di questa Ŕ fornita un'immagine
che risale al 1985. In quest'ultimo tratto si passa accanto ad alcuni macigni di scaglia
rossa, qui depositati dal ricordato ghiacciaio del Cism˛n, che nella zona di Ponte d'Oltra
lambý pareti di roccia di questo tipo.
uno strano calanco, isolato: Ŕ chiaro che uno strato di materiale di
spessore superiore all'altezza del calanco Ŕ stato asportato dalle frane in tempi non
molto remoti (vedi l'immagine dello stesso nel
1985); anche a
valle emerge un altro calanco, e sono presenti altre briglie che hanno ormai stabilizzato il terreno. Si risale una costa con rada vegetazione di stentati
carpini e ornielli, tipici di ambiente secco e terreno non profondo, e si ha di fronte una frana imponente (B˛e de Rubýn), che si
sta mangiando la sommitÓ di una
collina: anche di questa Ŕ fornita un'immagine
che risale al 1985. In quest'ultimo tratto si passa accanto ad alcuni macigni di scaglia
rossa, qui depositati dal ricordato ghiacciaio del Cism˛n, che nella zona di Ponte d'Oltra
lambý pareti di roccia di questo tipo.
I diffusi interventi
di bonifica delle frane effettuati nella prima metÓ del secolo scorso hanno
avuto successo, e il terreno non presenta nuovi smottamenti; i due calanchi che,
isolati, emergono dal terreno circostante coperto di
vegetazione, sono gli epigoni e la testimonianza delle antiche profonde
erosioni; le numerose piccole briglie ancora intatte sono
idonee a contrastare le frane; di queste, ne rimangono ancora due consistenti, la B˛a de
Rubýn e quella sul fianco destro della Val dei Corn, entrambe quasi giunte alla parte
sommitale delle colline attaccate.
Ancora poche decine di passi sul sentiero che si impenna negli ultimi metri, e
arriviamo sul pianoro vicino alla vecchia mulattiera detta "strada bassa"
(a ridosso dl monte),
seguendo la quale in 1/4 d'ora si pu˛ scendere a Porcen. In poco pi¨ di cinque
minuti si arriva al punto di partenza, CostesŔle: si prende, a sinistra,
il sentiero che sfiora il bordo della frana e passa per Rubýn, due case abitate
nei primi anni del secolo scorso; di qui ancora
a sinistra
su sentiero pianeggiante, tra vecchi moronŔr e giovani piante di castagno
innestate di recente, perchÚ producano marroni.
Stupisce il fatto che la misera Italia dei
governi pre e post-I guerra mondiale prima, poi l'autarchica e velleitaria Italia fascista
intervenissero nella difesa del suolo in modo pi¨ deciso e razionale dei governi
degli ultimi cinquant'anni, che con le
loro presunte "grandi opere" (TAV, ponte di Messina, BreBeMi,
Pedemontana veneta, Veneto City, ...e il MOSE!) non perdono occasione per ferire e violentare
la terra: quelli miravano al risanamento dei territori di montagna, perchÚ di lÓ
parte tutto il materiale che provoca lo straripamento dei fiumi in pianura,
questi hanno provveduto -non sempre e con gravi ritardi- solo a tamponare le falle, e non pensano a
realizzare un
programma di interventi per la prevenzione da eventi dannosi. La
"filosofia" dominante, fatta propria anche dalla maggioranza della popolazione,
perchÚ ad
essa imposta con tutti i mezzi possibili dalle
plutocrazie dominanti, Ŕ quella
dello sfruttamento di ogni bene, quindi anche dell'ambiente, per trarne profitto
immediato: non si pensa al furto che, cosý operando, si arreca alle
future generazioni.